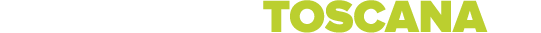I paesaggi rurali della Toscana

I caratteri originali del paesaggio rurale toscano si costituiscono nei secoli dopo il Mille allorché – per la ripresa politica, demografica ed economica delle città, per la loro crescente domanda di prodotti agricoli-zootecnici anche in funzione dell’industria, e per i loro graduali investimenti fondiari e agrari nelle campagne – entra in crisi e si disgrega rapidamente il sistema feudale curtense.
Tale organizzazione territoriale aveva largamente improntato l’Italia e l’Europa centro-occidentale dall’alto Medioevo con forme generali nonostante le rilevanti differenziazioni ambientali (geomorfologiche e climatiche). Questa realtà, creatasi in seguito alla crisi delle città in epoca tardo-antica, si era basata su una miriade di piccole comunità contadine di autoconsumo assoggettate ai poteri signorili, concentrate in castelli o villaggi non fortificati.
Tali comunità avevano elaborato un paesaggio produttivo assai semplificato, basato quasi esclusivamente su campi mantenuti aperti (privi cioè di recinzioni) coltivati a cereali, disposti a corona intorno agli abitati, utilizzabili anche per il modesto allevamento di ovini, equini e bovini. Il bestiame fruiva, come pasture, soprattutto gli appezzamenti che, dopo la coltura cerealicola, erano lasciati a riposo per uno o più anni; subito al di là dei coltivi si estendeva l’ambiente dei boschi, degli incolti e – nelle pianure – degli acquitrini che era riservato in modo pressoché esclusivo ai bisogni (allevamento estensivo, pesca) e ai piaceri (caccia) della feudalità laica ed ecclesiastica.
Lo sviluppo del sistema urbano – con la conseguente disgregazione e scomparsa del sistema feudale tra i secoli XII-XIV – portò alla nascita di nuove organizzazioni territoriali e di nuovi tipi di paesaggio rurale, sulla base dell’intreccio di fattori fisico-naturali (varietà dei caratteri del clima specialmente in rapporto all’influenza del mare e dell’altitudine, delle forme del terreno e dei caratteri pedologici e del grado di permeabilità dei suoli) e di fattori umani (diversa incidenza, in termini di polarizzazione, da parte della città e del suo mercato anche in relazione alla distanza o posizione geografico-topografica delle aree e dei luoghi agricoli, diverso impegno imprenditoriale della proprietà fondiaria).
Semplificando, per la Toscana tardo-medievale si è parlato di una vera e propria tripartizione agraria (e quindi paesistica, sociale ed economica), pur non mancando altre specifiche Toscane minori.
Le tre grandi partizioni paesistiche e sociali essenzialmente sono:
1) la Toscana del piano-colle interno del podere a mezzadria (fin dal Rinascimento spesso gradualmente inserito nell’assetto di fattoria), ovvero la “Toscana delle città”, che (nell’area fiorentina) veniva percepita come il più bello e (come scrisse il grande storico Fernand Braudel subito dopo l’ultima guerra mondiale) il più commovente paesaggio del mondo. Un paesaggio con la maglia fittamente appoderata e alberata, le sue tante case coloniche e le sue tante ville isolate, molte delle quali via via organizzate in centri di fattoria dalla grande proprietà cittadina che controllava la terra. Ma la mezzadria produceva anche il paesaggio meno apprezzato – da viaggiatori stranieri, scrittori ed artisti di ogni epoca, fino alla prima metà del XX secolo – della Toscana senza dolcezza d’alberi o del latifondo a mezzadria (estesa nelle colline argillose del Senese e del Volterrano-Pisano), con i suoi grandi poderi a ordinamenti colturali estensivi.
2) la Toscana montana delle comunità di villaggio dell’Appennino, delle Apuane e dell’Amiata, tradizionalmente percepita come il mondo socializzato e in sostanziale equilibrio ambientale e sociale dei borghi contadini, del castagneto e del bosco, delle praterie e dell’allevamento stanziale e transumante.
3) la Toscana pianeggiante e collinare costiera del latifondo (attuali Maremme di Livorno già di Pisa e di Grosseto già di Siena), tradizionalmente percepita come il mondo selvaggio privo della ‘luce’ della città e poco frequentato dall’uomo, con il dominio dell’incolto e della caccia, dell’agricoltura estensiva esclusivamente a grano e della pastorizia, dell’acquitrino e della malaria, della miseria sociale ed economica diffusa a causa della grandissima concentrazione fondiaria della terra in mano a proprietari cittadini assenteisti.

La Toscana del podere a mezzadria
Ovviamente la diversità dei paesaggi riscontrabili nella Toscana poderale – rimasta relativamente integra fino alla dissoluzione del sistema mezzadrile negli anni del miracolo economico (pur con le innovazioni dei secoli XVIII-XX, quali l’espansione della maglia aziendale e delle colture arboree e l’introduzione di efficaci sistemazioni idraulico-agrarie orizzontali e di rotazioni continue, oltre che di nuove piante da industria: mais, tabacco, barbabietola, eccetera) – è il prodotto delle varietà dei sistemi agrari in termini subregionali e locali.
E ciò riguardo all’incidenza dei seminativi nudi e dei seminativi arborati (con presenza o meno di colture intensive e irrigue per alimentare quotidianamente i mercati cittadini più vicini con primizie ortofrutticole), delle piantagioni arboree e del castagneto da frutto, della diffusione dei prati-pascoli e del bosco, delle sistemazioni idraulico agrarie e forestali specialmente collinari (necessarie a mantenere in equilibrio terreni spesso di delicata costituzione fisiografica), della densità e della tipologia delle case contadine e delle residenze padronali con le loro pertinenze funzionali, rispettivamente, al lavoro (aie e resedi) o agli svaghi (parchi e giardini, boschetti organizzati per la caccia, viali alberati e piante ornamentali).
Trattasi del classico paesaggio a policoltura più o meno intensiva tipico della mezzadria poderale, vale a dire i seminativi arborati, con diffusione sia in piano che specialmente in colle, spesso con alternanza a boschi e a pascoli (essenzialmente in collina), con unità di produzione a misura familiare, o poderi, di dimensioni ridotte (in media meno di una decina di ettari), e consistenti solo di coltivi o aventi comunque una prevalenza netta del “domesticheto” sulle altre destinazioni d’uso dei terreni (appunto boschi, pascoli e incolti asciutti o umidi) che era soprattutto espressione delle aziende prossime alle città e ai centri abitati minori. Qui, il suolo era spesso tutto o quasi tutto alberato, salvo le consuete fasce di “posticce” e “alberete” (salici e pioppi), ovvero vegetazione arborea piantata con funzioni di difesa idraulica lungo i corsi d’acqua.
Non pochi poderi erano soliti integrare, nel sistema di piano-colle, le colture alberate o il seminativo nudo con il bosco governato a ceduo o tenuto a fustaia pascolata e non di rado con l’incolto per pascolo in collina.
Non fosse altro che per le differenze climatiche, diverso era il paesaggio dell’alta collina. Qui il paesaggio tipico dell’alberata si integrava con ampi terreni adibiti a seminativo nudo, ma anche con estese aree a bosco pasturabile e a bosco ceduo (e non di rado a castagneto), che sui rilievi più elevati finivano spesso con il prevalere o addirittura dominare: è il caso delle Colline Metallifere, dove peraltro la grande proprietà e la mezzadria poderale si alternavano con la piccola proprietà e la conduzione diretto-coltivatrice (e con i demani collettivi e gli usi civici) degli agricoltori residenti nei tanti castelli compatti dell’area.
Connotati del tutto particolari erano poi dati dai paesaggi estensivi delle Crete senesi e volterrane-pisane di Val di Cecina e Val d’Era, per il predominio delle coltivazioni a seminativi nudi e degli incolti utilizzati per il pascolo (pasture spesso con presenza di rade boscaglie o di pochi alberi sparsi, oltre che di fenomeni di erosione in ambiente collinare), rispetto ai boschi (presenti in via eccezionale nelle parti più adatte del “cattivo terreno”, quello cioè prevalentemente od esclusivamente argilloso punteggiato da calanchi e biancane).
Non mancavano, qui, piccole chiuse arborate: sorta di minuscoli giardini recintati (con siepi vive o morte, ma anche con muretti a secco di pietrame) e adibiti a colture arboree di pregio, soprattutto viti, secondariamente olivi, alberi da frutto, mori o gelsi, e a colture orticole.
Il fine di tale pratica, le cui matrici sono da riferire al sistema alto-medievale, ovviamente, era quello di proteggere le colture intensive dai danni che poteva arrecare il bestiame, che in quelle aree si usava tenere ancora allo stato brado in sistemi di campi aperti, nei quali i seminativi nudi si alternavano, appunto, con lunghi riposi a pastura. Dalla crisi e disgregazione della mezzadria (esplosa alla fine dell’ultima guerra per ragioni sia economiche che sociali) sono nati – insieme con i paesaggi rivestiti dall’urbanizzazione o con i paesaggi dell’abbandono e della rinaturalizzazione o della riforestazione pianificata – nuovi paesaggi rurali, assai più uniformi degli antichi, prodotti dalla riconversione di mercato attraverso la riorganizzazione del sistema economico (ora basato sulla specializzazione colturale, in seccagno e in irriguo, sulla meccanizzazione e sull’azienda capitalistica con salariati oppure sulla conduzione diretta da parte di piccoli proprietari, acquirenti di poderi dalla grande proprietà tradizionale che si è spesso ridimensionata), a prezzo della dismissione di un grande numero di case contadine e ville signorili, quasi sempre riconvertite a funzioni extragricole o non di rado versanti ancora in stato di abbandono.
Al paesaggio delle colture promiscue e dell’insediamento sparso apparteneva anche la piana di Lucca, detta delle Sei miglia (a Capannori e Porcari), con la sua specificità delle corti. Trattasi di un sistema agrario del tutto originale per la Toscana. Nonostante il costituirsi – anche nella Lucchesia – di un sistema alquanto fitto di ville padronali fin dai tempi rinascimentali, il ruolo della fattoria appoderata rimase sempre modesto: fin dal tardo Medioevo, gran parte dei terreni erano condotti, con il sistema del livello enfiteutico o dell’affitto, da piccole imprese contadine che non disponevano dei capitali sufficienti a introdurre migliorie agrarie. Con le riforme dei governi francesi, moltissimi coltivatori poterono diventare proprietari o possessori livellari perpetui e la maglia aziendale (incentrata tradizionalmente sulle corti, vale a dire su più corpi edilizi monofamiliari che, con i loro annessi, si disponevano intorno ad uno spazio comune, generalmente aperto, organizzato ad aia con pozzo) si infittì vistosamente.
La piana di Lucca, con le colline che la circoscrivono a nord e a sud, assunse la fisionomia di un vero e proprio giardino dalla proprietà frammentata: diviso in tanti piccoli appezzamenti regolari delimitati da scoli e filari alberati con viti, gelsi e alberi da frutta, intensivamente coltivati – sepsso anche con ricorso all’irrigazione – da famiglie numerose di coltivatori diretti. Nell’ultimo dopoguerra, anche questo sistema paesistico è stato fortemente destrutturato dall’avanzata dell’urbanizzazione residenziale e produttiva e dalla riconversione agraria delle aziende residue, incentrata ora sulle monocolture (specialmente mais e seminativi industriali).
Altro paesaggio originale è quello delle poche aree di pianura di bonifica sistemate – tra la fine del XV e l’inizio del XVII secolo – con ordinamenti colturali “alla lombarda”, vale a dire con cascine capitalistiche – di proprietà soprattutto granducale alle Cascine di Firenze e di Prato, a quelle di Buti e di Bientina, di San Rossore e di Coltano (ma non esclusivamente granducale, come dimostra quella di Migliarino-Vecchiano dei Salviati) – imperniate su monocolture risicole e foraggere (funzionali a grandi allevamenti bovini da latte e carne).
Qui, però, rispetto ai grandi spazi padani, le geometriche praterie e risaie, delimitate da filari di pioppi o di gelsi – come dimostra il caso della tenuta del Poggio a Caiano con le annesse Cascine di Tavola (Prato) – con il tempo, dal XVI secolo e soprattutto successivamente, furono di regola: o contornate da vicino dall’alberata di tipo semplificato (filari di sole viti allevate alte all’acero campestre), propria delle aree di bonifica recente, con estesi poderi gestiti da famiglie mezzadrili; o parzialmente indirizzate verso l’allevamento anche estensivo di ovini e cavalli, con utilizzazione dei vasti boschi e incolti a pastura presenti (come nelle cascine pisane granducali e dei Salviati). Nonostante la ripresa ottocentesca con l’apertura di non poche nuove aziende – in Valdinievole, Valdarno di Sotto e pianura pisano-livornese, Val di Chiana e Mugello-Romagna Toscana – da parte di imprenditori che guardavano al modello della cascina padana, dimensionate sul binomio foraggi-bovini da latte e da carne, le cascine toscane hanno risentito fortemente (con tanto di chiusura e ridimensionamento) della crisi in cui da tempo versa la zootecnia italiana.

La Toscana della montagna
È storicamente incardinata sull’accentramento insediativo, sotto forma di castelli e villaggi anche piccoli che rappresentano microcosmi di vita socio-culturale ed economica, grazie soprattutto agli interessi comuni in materia di gestione collettiva e razionale – in termini di salvaguardia dell’ecosistema d’insieme – dei boschi e pascoli, talora anche dei castagneti e dei coltivi di proprietà comunale o gravati da diritti di usi civici). La grande maggioranza della popolazione si articolava nella piccola proprietà spesso particellare diretto-coltivatrice e sul sistema agro-silvo-pastorale, di norma integrato dalle cospicue migrazioni stagionali (specialmente di pastori transumanti) verso le aree maremmane, e non di rado da occupazioni nei settori dell’artigianato soprattutto del legno o delle attività estrattive (come il marmo nelle Apuane). Ciò, approfittando anche delle aperture (e quindi delle possibilità di commercio) offerte dalle storiche migrazioni stagionali dei montanini e dalla presenza di innumerevoli vie di valico o di attraversamento colleganti le aree montane con quelle sottostanti toscane e padane.
La struttura produttiva montana (dell’Appennino, delle Apuane e dell’Amiata e persino di lembi dell’alta collina chiantigiana e metallifera) era fatta di economie familiari precarie alla continua ricerca di sbocchi occupazionali e di risorse per la sopravvivenza. Essa usava tradizionalmente, con le piccole aziende polimeriche (frazionate cioè in più corpi), tutte le risorse stratificate dal fondovalle o dalle fasce inferiori fino ai crinali: vale a dire, i pochi terreni nei versanti meglio esposti ridotti a terrazze per la coltivazione di modeste produzioni di cereali, legumi e alberi da frutta e dal primo Ottocento della patata (con nell’Amiata anche una forte presenza, alle quote più basse, delle colture di viti e olivi), i castagneti e i boschi di cerro e prevalentemente di faggio ovunque dominanti (sfruttati per il pascolo e per ricavarne legname da costruzione e da ardere o carbone), i prati-pascoli naturali e per lo più artificiali d’altura, sempre con appezzamenti (in proprietà, in possesso enfiteutico o con diritti d’uso nelle grandi proprietà silvo-pascolative degli enti ecclesiastici e dei comuni) presenti anche nelle diverse fasce altimetriche.
L’allevamento soprattutto ovino, praticato spesso per finalità di mercato in boschi e pasture anche comunali, e la coltivazione del castagno (vero albero del pane per la cronica carenza dei prodotti cerealicoli), in continuo sviluppo fino al primo Novecento, costituivano i fondamenti economici delle ‘piccole patrie’ appenniniche e amiatine. Grazie all’uso integrato dei beni locali propri e collettivi, alla versatilità professionale e alla mobilità degli abitanti, e grazie pure alle forme di vita molto socializzate, almeno fino allo scadere dell’Ottocento la società della montagna era povera, ma non miserabile e bisognosa di assistenza pubblica, a differenza delle regioni della mezzadria e del latifondo, dove la miseria connotava il sempre più esteso ceto dei sottoproletari (i braccianti detti pigionali che non possedevano bene patrimoniale alcuno).
La crisi del sistema agrario montano si rivelò per gradi nel corso del XIX e dei primi decenni del XX secolo – con tanto di contrazione dell’allevamento, abbandono dei terreni a coltivazioni e a castagneto da frutto ed emigrazione definitiva di molti agricoltori – ed è dovuta a vari fattori, come l’avvio di processi di squilibri idrogeologici (con tanto di impoverimento delle risorse agro-silvo-pastorali montane) dopo la liberalizzazione dei tagli boschivi approvata nel 1780, che condusse ad una vasta distruzione del patrimonio forestale; la soppressione dei diritti di uso civico e la vendita dei beni comunali (vendita che finì per alimentare la formazione di una proprietà borghese che si organizzò spesso con poderi a mezzadria detti cascine, il cui ordinamento produttivo era incentrato su castagno, bosco e allevamento).
Ma anche la bonifica e la colonizzazione agraria delle Maremme di Pisa-Livorno e di Siena-Grosseto, che offrirono occasioni di lavoro stabile (con conseguente trasferimento definitivo) a molti abitanti della montagna; la patologia del castagno; la forte frammentazione delle piccole proprietà a causa delle divisioni ereditarie. Solo dopo la legge forestale del 1923 la critica realtà ambientale dell’Appennino e dell’Amiata (quest’ultima nel frattempo investita dall’industria mineraria del mercurio) tornò ad essere in larga misura recuperata, mediante estese opere di riforestazione (a base prevalentemente di conifere) e di sistemazione idraulica, che dovevano proseguire fino all’ultimo dopoguerra.

Le Maremme del latifondo
I malarici territori costieri di Pisa-Livorno e di Siena- Grosseto fin dal tardo Medioevo erano organizzati dal grande o immenso latifondo di persone giuridiche e fisiche di Firenze, Siena e Pisa, e contraddistinti da un’agricoltura a carattere assai estensivo, quale la cerealicoltura a lunghe vicende connessa con l’allevamento brado stanziale e con il sistema armentizio transumante. La zootecnia si appoggiava, oltre che sui terreni agrari tenuti a riposo per qualche anno dopo la cerealicoltura (ordinamenti a terzeria e quarteria), componente generalmente minoritaria, sulle macchie sempreverdi (in parte governate a ceduo) e sugli incolti sfruttabili come pasture (comprese le grandi e piccole zone umide spesso fruite anche per la pesca).
Larga parte delle Maremme continuò per secoli a rappresentare un autentico deserto umano, animato solo da pochi casali (centri direttivi dei latifondi che ospitavano alcuni salariati fissi e più numerosi braccianti stagionali) e soprattutto da capanne e ricoveri temporanei degli avventizi che stagionalmente scendevano in gran numero dall’Appennino, dall’Amiata e dalle Colline Metallifere, come pastori, boscaioli, carbonai, vetturali, giornalieri agricoli, operai della bonifica, artigiani, imprenditori e faccendieri, pinottolai, ecc. I coltivi arborati costituivano ristrette “isole” o corone (protette in chiuse o recinti delimitati da siepi morte o vive o da muraglie), per salvaguardare tali preziose piante dal morso del bestiame brado intorno ai radi e compatti castelli e villaggi rurali situati nelle colline interne fino all’Amiata, che ospitavano pressoché tutta la poco numerosa popolazione residente nel territorio.
Solo a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, l’avanzata della bonifica lorenese (con le operazioni di natura stradale e idroviaria, le alienazioni fondiarie, l’abolizione dei beni comuni, degli usi civici e del compascuo, l’impianto delle pinete sui tomboli costieri) e della colonizzazione agricola contribuì a trasformare, seppure con molta lentezza, gli elementari connotati paesistici e aziendali, indirizzandoli verso stadi più maturi e complessi.
Il fenomeno fu particolarmente vistoso e lineare – oltre che nei bacini interni ed inizialmente acquitrinosi della Toscana (Valdichiana, Valdinievole e Bientina) e nella pianura costiera pisano-livornese, dove i poderi e le fattorie a mezzadria, di proprietà di enti e famiglie cittadini, cominciarono a nascere nei tempi medicei (secoli XVI-XVII) – nella Maremma Pisana oggi Livornese, dove nei tempi lorenesi avanzarono bonifica e colonizzazione mediante appoderamento mezzadrile.
La riterritorializzazione fu invece assai più lenta e contrastata nella Maremma Grossetana, dove i mutamenti di tipo quantitativo e qualitativo avvennero, per quasi tutto l’Ottocento, quasi esclusivamente con la gran coltura cerealicola e l’allevamento quasi sempre brado, praticati pur sempre all’interno dei latifondi. Soltanto nell’interno collinare, le grandi proprietà furono in parte colonizzate con l’apertura di poderi mezzadrili o condotti con altri patti di colonìa (come la quarteria). In pianura, invece, soltanto dalla fine del XIX alla seconda guerra mondiale la bonifica poté dirsi conclusa e i vari comprensori furono allora largamente appoderati a mezzadria; un impulso assai forte alla colonizzazione delle aree di latifondo venne poi dato dagli espropri e dalle assegnazioni di terre della riforma agraria del 1950.
Fino alla metà circa del XVI secolo, la pianura costiera a nord del fiume Serchio – frazionata fra gli Stati della Repubblica di Lucca (Viareggio e Montignoso), del Granducato di Toscana (Pietrasantino) e del Ducato di Massa e Carrara (litorale fra Magna e fosso di Cinquale) – esprimeva un paesaggio molto simile a quello del latifondo della Toscana costiera a sud del Serchio: era infatti priva di insediamenti stabili e ricoperta da acquitrini insalubri, incolti umidi e asciutti, boschi sempreverdi e decidui, tutti ambienti fruiti stagionalmente per il pascolo, le semine saltuarie e la pesca dagli abitanti residenti nelle colline e nelle montagne restrostanti delle Apuane.
Mancava però qui la grande proprietà cittadina che dava vita al latifondo dei territori litoranei di Pisa, Piombino, Grosseto e Orbetello, perché i suoli erano quasi tutti di proprietà comunale o statale e gravati di diritti di uso civico a vantaggio delle popolazioni locali. Siamo quindi in presenza della realtà del paesaggio delle comunanze e piccole proprietà apuano-versiliane che nell’età moderna andò gradualmente a costituirsi con trasformazione in agricoltura intensiva e anche in agricoltura specializzata (in prodotti orticoli con impianti di alberi da frutta e piccoli vigneti o di oliveti a bosco nelle pendici collinari del Pietrasantino e delle vicine comunità lucchesi) ad opera specialmente della piccola, ma anche della media proprietà (con tanto di costruzione dei primi insediamenti aziendali in forma di piccole case dei coltivatori diretti e di un assai minor numero di mezzadri). E ciò, via via che gli Stati interessati procedevano – tra la seconda metà del XVI e la prima metà del XIX secolo – alla sistemazione idraulica dei brevi corsi d’acqua che scendono dai monti e alla bonifica degli acquitrini presenti e alla concessione dei terreni mediante vendita o allivellazione, spesso con obblighi miglioritari dell’ambiente e dell’impianto della pineta nel tombolo fino ad allora occupato dalla macchia mediterranea.
Diversa da tutte le altre aree è la realtà storica dell’Arcipelago Toscano. Rispetto al territorio della costa maremmana, infatti, le isole toscane maggiori, ovvero Elba, Giglio e Capraia, che – contrariamente alle altre minori (Gorgona, Pianosa, Montecristo e Giannutri) – mantennero una continuità di popolamento dal tardo Medioevo, costituiscono un mondo a parte, esprimendo forme paesistiche e strutture socio-economiche assai specifiche, per certi aspetti abbastanza simili a quelle montane appenniniche.
Le popolazioni insulari, per lo più organizzate in piccoli centri murati e villaggi aperti mantenenti forti legami comunitari, e ancora più mobili di quelle appenniniche, si inserirono saldamente nell’economia e nella cultura mediterranea, specialmente grazie alle ricolonizzazioni dei tempi moderni. Tale integrazione avvenne mediante le pratiche della pesca, del contrabbando, del commercio delle eccedenze locali (vino, pescato, sale), oltre che del minerale di ferro o del granito all’Elba (e in minor grado al Giglio). Con tali risorse, gli agricoltori isolani – residenti tutti nei paesi quasi sempre fortificati – erano soliti integrare le mediocri produzioni agricole (con le terre quasi esclusivamente collinari ovunque intensivamente utilizzate mediante ingegnosi terrazzamenti e l’impianto di colture anche specializzate, a partire dalla vite) e gli stipendi versati dagli Stati preunitari per mantenervi solidi presìdi militari, al fine di controllare, da questi avamposti, i nodi di traffico marittimo di rilevante importanza strategica. I governi dei tempi unitari, con la smobilitazione militare, la repressione del contrabbando e la crisi della navigazione di cabotaggio, e spesso con la localizzazione di colonie penali già pionieristicamente sperimentate dal Granducato intorno alla metà del XIX secolo, infersero un colpo mortale a queste ‘piccole patrie’ insulari. E lo dimostra l’attivazione, proprio da allora, dell’abbandono dell’agricoltura e dell’avvio di un continuo movimento migratorio che doveva finire per decimare la popolazione e destrutturare molti microcosmi, fino alla ‘valorizzazione’ turistica: una colonizzazione diretta da imprenditori quasi sempre esterni, pregiudizievole nei riguardi degli equilibri paesistico-ambientali e socio-culturali delle comunità isolane, affermatasi compiutamente nella seconda metà del XX secolo.
Analogo a quello insulare era il paesaggio rurale prodotto – fino allo sviluppo turistico dell’immediato ultimo dopoguerra – nel promontorio dell’Argentario, nei versanti terrazzati e nelle ‘corone’ di proprietà particellare circostanti Porto Santo Stefano e Porto Ercole, tenuti a coltivazioni intensive (per lo più vigneti, ma anche alberi da frutta e ortaggi) dagli abitanti dei piccoli centri portuari, agricoltori e insieme pescatori e marittimi, non di rado tradizionalmente provenienti dal Napoletano, dalla Spagna e da altri paesi dominati fino al XIX secolo dagli Asburgo.